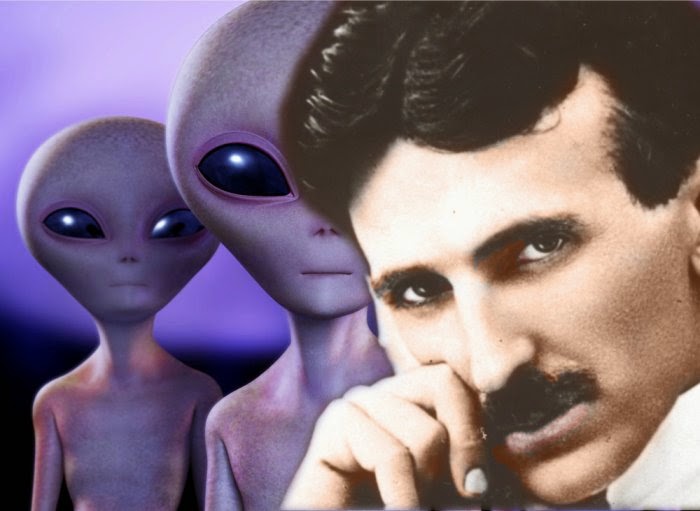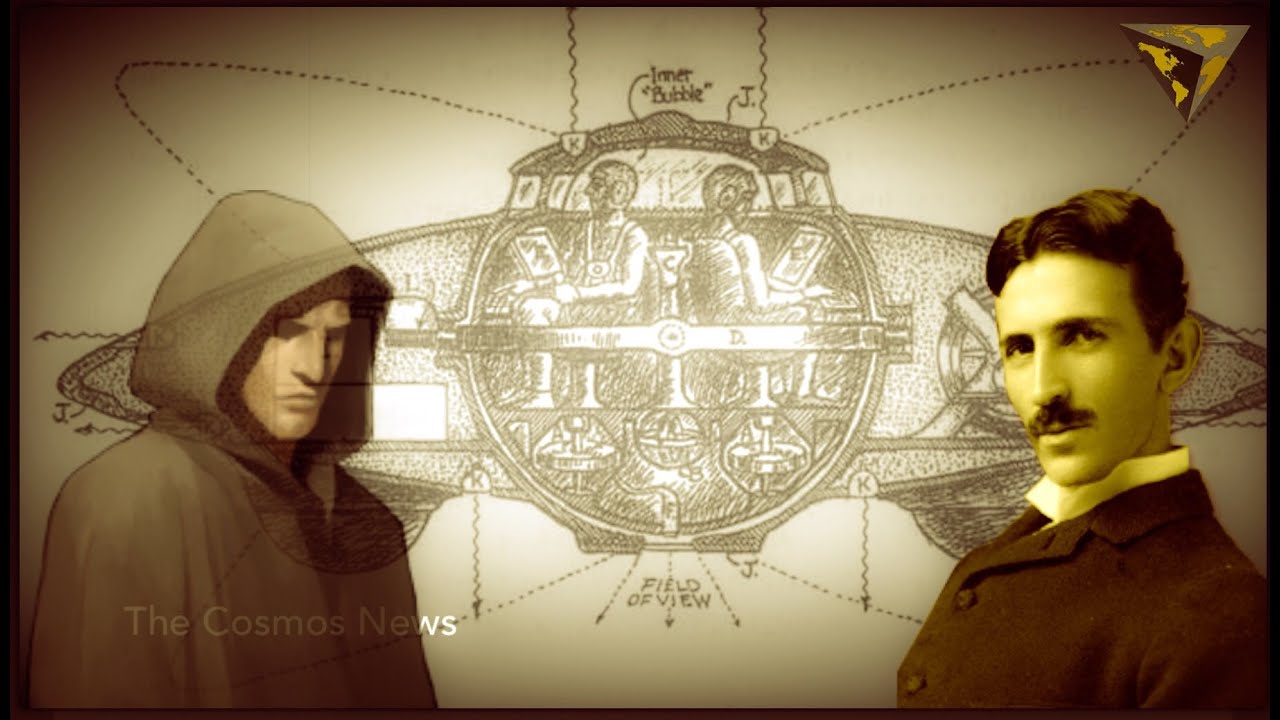LE TERRE DEL SACRAMENTO
Il romanzo è pubblicato postumo, nell’estate del 1950, perché l’autore è morto in Aprile, senza aver potuto rivedere neppure le bozze di stampa. E’ il testamento letterario di Jovine sia perché è l’ultima opera sia per la piena maturità ideologica ed artistica.
Alla grande maggioranza di critica appare la più distaccata artisticamente ed insieme la più “engagée”, di un impegno “naturale”.
La maturità conseguita da Jovine è il frutto di un lungo cammino percorso dalla sua poetica e del lento, costante formarsi di una coscienza civile e politica. Le terre del Sacramento rappresentano, pertanto, il punto di congiunzione, l’armonia tra poetica e ideologia, sono la naturale conclusione artistica di un processo che è iniziato sin dalle prime opere ed è poi pervenuto al neorealismo e al marxismo.
E’ inesatto parlare di repentine conversioni al realismo o di “garanzie” richieste all’ideologia, come precisa con chiarezza Dina Bertoni Jovine:
L’itinerario spirituale di Jovine fu del tutto opposto. Jovine è partito da aspirazioni generose ma forse confuse; attraverso esperienze mentali e morali profondamente sofferte e meditate, ha scoperto via via la sua verità arrivando all’essenza dei problemi.
Egli poteva dunque dirsi da principio “un illuminato”, ma non gravitò certo verso la sinistra politica chiedendo alla ideologia delle garanzie impossibili. Al contrario ero una coscienza viva e critica, tormentata da dubbi, continuamente assillata da esigenze di approfondimento, orientato a cercare questo approfondimento nella realtà della storia e capace di identificare il nocciolo dei problemi e di affrontare i contrasti nella loro crudezza (D. Bertoni Jovine, in Il contemporaneo, luglio-agosto 1960).
In Jovine, la convergenza col marxismo avviene, più che altro, sui problemi concreti: la “questione meridionale” (sempre studiata e posta a sfondo delle sue opere) ed il rinnovamento culturale su base nazionale-popolare (concetto accolto da Antonio Gramsci ma già elaborato per proprio conto in scritti giovanili).
Lo scrittore, che ha ereditato un forte senso storico da Francesco De Sanctis e da G. Battista Vico, lo approfondisce con le idee di Gramsci; acquista una nuova consapevolezza della questione meridionale, riflette sulle opere di G. Fortunato, di G. Salvemini) ed indaga egli stesso le cause dei fenomeni rivoluzionari e politici nella storia del Mezzogiorno dal 1799 in poi.
Elabora l’articolo Come ho visto la questione meridionale (in La Voce, 19 dicembre 1947, ora in Viaggio nel Molise, a cura di N. Perrazzelli, op. cit.), in cui rileva che solo la terra è sempre stato il “termine ultimo della contesa” tra varie classi sociali: aristocratici, borghesi e contadini.
Tale molla ha spinto nel 1799 all’alleanza tra proprietari feudali e contadini contro la borghesia giacobina, e nel 1860 a quella dei contadini con i borbonici, contro i piemontesi e contro i nuovi proprietari della terra: i borghesi, i “galantuomini”, i professionisti, che si sostituivano ai vecchi padroni feudali.
“Il cafone sapeva che tra i due padroni, il duca o il marchese … che conosceva appena l’ubicazione delle loro terre, e l’avvocato, il notaio, l’usuraio locale… che conosceva il valore del denaro, che era la sua arte di dominio, preferiva il duca o il marchese” (cfr. art. cit.).
A fine ‘800, in piena emigrazione, la terra agognata fu acquistata dai contadini con le rimesse dall’estero mentre i borghesi si impoverivano proprio per l’”esodo migratorio che aveva privato di braccia le campagne”. Nel ’24, però, quando l’emigrazione si chiuse, le condizioni economiche e psicologiche del Mezzogiorno tornarono stentate e drammatiche come un secolo prima. Cosicché la campagna d’Etiopia ebbe molti volontari nel Meridione: quello che il fascismo scambiò per patriottismo era soltanto povertà e fame.
Alla luce di tali studi e riflessioni, il romanzo ha due elementi di fondo, fra loro complementari: il danaro per pagare la terra e le braccia per lavorarla.
La “coscienza politica di Jovine si fa radice di quella morale e fantastica” (G. Giardini, F. Jovine, Marzorati, Milano, 1967, p.60).
E tuttavia, - ha subito notato Luigi Russo -, “la sua fede politica era così pura e filtrata, che poteva essere taciuta nei suoi filosofemi, perché tutto si era disciolto nel sangue e in ogni particolare della fantasia. Nella civiltà pacifica del lavoro la sua Musa attinge con naturalezza e senza polemica, la propria linfa” (L. Russo, I narratori, Principato, Milano, 1951, p.333).
Una poetica sincera e umana, tanto insita nella natura di Jovine che, malgrado il forte contenuto sociale, il romanzo non ha toni accesi o di persuasione propagandistica, non ha l’enfasi del neofita, non propone divisioni manichee tra i personaggi.
E’ maturata anche la capacità di esporre obiettivamente la realtà; scompaiono le posizioni critiche, gli atteggiamenti ironico-parodistici di alcune opere precedenti.
L’autore ama dello stesso amore tutte le creature della narrazione perché ognuna di esse apporta alla storia un elemento né positivo né negativo bensì essenziale e
l’essenzialità viene non tanto dalla appartenenza di ceto o di classe, quanto dal vincolo che in un modo o nell’altro accomuna tutti alla terra, matrice prima di ogni speranza e di ogni desiderio. Sì che la polemica, se esiste, è trasportata in un contesto naturale, quello dei terreni da coltivare e da migliorare… Le terre del sacramento conferma così il proprio titolo.
E’ il libro, il poema della terra, dell’angoscia di possederla, di amarla, le difficoltà, una volta ottenuta, di tenerla; il pianto, il sudore, l’affanno delle coltivazioni, i magri prodotti e le semplici speranze, tutto vuole concorrere a ciò, e tutto a questo punto di vista si rapporta (M. Grillandi, op. cit. pp. 70-71).
Lo studio monografico di G. Giardini insiste a lungo sulla tesi che la terra è il tema unitario del romanzo.
Tutti i personaggi nelle loro vicende essenziali sono strettamente legati alla terra: lo stesso Enrico Cannavale; Laura, con “il suo umano dramma di donna coraggiosa e vinta”; Luca, che matura umanamente solo quando si occupa direttamente dei problemi della terra.
Ma della terra e per la terra vivono i contadini, e il loro amore per essa è comune e intimo all’autore.
La terra è vista nel vario avvicendarsi delle stagioni, con le caratteristiche che essa assume via via e le sciagure e la miseria che essa porta finché è abbandonata a se stessa.
E i contadini curano la poca terra che possiedono con un attaccamento quasi religioso, chè la terra nella loro mente (e in quella dell’autore) assume quasi l’atteggiamento umano di una creatura buona e grande, senza cui impossibile è la vita.
La necessità del lavoro e del pane congiunge quasi con disperazione il contadino alla terra; egli ne sana le piaghe, le coltiva con amore, le sente e rivive in se stesso, nella parte più intima della sua anima.
Ma è in virtù di questo attaccamento alla terra che essi riescono a vincere la superstizione che grava sul fondo del Sacramento e offusca la coscienza stessa dei loro diritti.
La terra diviene così l’atmosfera corroborante e il motivo animatore del libro: se non acquista l’individualità di un personaggio, si articola nei personaggi e nelle vicende e ne costituisce il tema unitario (G. Giardini, op. cit. pp. 70-71).
A sua volta, Sebastiano Martelli (in F. Jovine, Casa molisana del libro, Campobasso, 1970, pp. 114-118) avanza alcune riserve sulla priorità data al tema della terra da parte di tutta la critica orientata
a vedere nell’opera di Jovine uno stretto legame con quella verghiana, una critica che ha sostituito al motivo verghiano della “roba” quello più moderno della “terra”. In realtà ci sembra che questo giudizio è un po’ in ritardo rispetto ad una tematica che ne Le terre del Sacramento appare più varia e complessa, una tematica che si permea di spunti ideologici, di critica storica, di crisi religiosa e che pone il romanzo in una dimensione diversa.
Certo la “terra” è un motivo costante del libro… l’habitat dei personaggi, ma tale motivo non esaurisce e non comprende tutta la problematica insita nel romanzo.
Pertanto, a Martelli si configura troppo restrittivo il collegamento Verga-Jovine dei critici Russo, Pancrazi, Giardini, che si basano sulla analogia di “rappresentazione corale della vita paesana”, “poetica dei vinti”, “lotta per la terra”, pur avendo essi rilevato le dovute differenze tra i vinti verghiani, - rassegnati alla loro sorte -, e i vinti joviniani, che lottano e maturano una coscienza sociale.
Martelli non nega l’influsso verghiano sull’opera di Jovine ma preferisce sottolineare nei due autori la diversità dei problemi storici e della ideologia.
Le terre del Sacramento sono nel contempo l’opera che colloca Jovine in primo piano nella narrativa realistica del dopoguerra.
L’”istanza realistica” non deriva da una conversione immediata né solo dalle contingenze storiche, politiche, culturali ma proprio perché è presente in tutta l’attività letteraria precedente e scaturisce da un’intima esigenza alla verità, alla sincerità della vita, ha modo di esprimersi con autonomia rispetto alle formule realistiche di quegli anni, spesso riduttive e coercitive.
Osserva N. Sapegno che nell’aderire alla poetica neorealistica Jovine non deve fare, come tanti altri scrittori di quella corrente, alcuno sforzo né ha bisogno di “rinnegarsi, di tentare frettolose conversioni di rotta… La sua adesione ad una tematica sociale si è maturata in lui e a poco a poco, negli anni, attraverso la sua umana e cordiale simpatia per i poveri e la crescente preoccupazione ai loro problemi.
Non gli occorre uscir fuori dal sua ambiente, mutare o capovolgere i termini del suo mondo sì soltanto di approfondirli…” (N. Sapegno, Pagine di storia letteraria, Manfredi, Palermo, 1960).
Si può concludere che, ben amalgamate con l’idea centrale della “terra”, nell’opera sono rifuse e sviluppate in vasta composizione di respiro storico, altre tematiche narrative dello scrittore: l’immobilità della provincia molisana, la difficile situazione dello studente di provincia, un sentito bisogno di rinnovamento cristiano, i problemi dell’urbanesimo e dell’industrializzazione, l’iniziale sviluppo del capitalismo nel Sud, il premere delle massi popolari.
La presenza e l’influenza di tutti quegli aspetti sugli avvenimenti narrati indicano la modernità e l’autenticità umana della poetica joviniana.
Le terre del Sacramento hanno una gestione lungamente meditata e maturata, cui accenna l’autore in un profilo autobiografico (in Fiera letteraria, 10 ottobre 1946): “Da dieci anni mi porto in mente un romanzo di vastissime proporzioni, senza titolo, per ora, ma con una decina di personaggi che mi fanno già ottima compagnia”; facendo riferimento anche ad un “nuovo romanzo” già iniziato, dal titolo La Capra del diavolo.
E’ probabile che, al tempo tra Signora Ava e il ’46, Jovine abbia avuto due momenti inventivi separati per due romanzi diversi, uno sulle vicende di Enrico Cannavale (La capra del diavolo) e uno su quelle di Luca Marano (il “romanzo di vastissime proporzioni”) e che poi sia nata la decisione di fondere i due nuclei narrativi, dando vita alle Terre de Sacramento ove si intreccia la decadenza di una famiglia borghese con la nascita di una coscienza sociale dei contadini.
Della Capra del diavolo lo scrittore dà un primo ritratto in Terra vecchia, un racconto del 1943 (in Giornale d’Italia, 7 febbraio), ambientato a Castelluccio Acquaborrana (oggi Castelmauro).
Invece, la situazione storica rappresentata nel romanzo, un sessantennio del contado di Molise in cui il “galantuomo” prevale sul “feudatario” ormai decaduto e indebitato, trova riscontro in altri scritti di quel travagliato decennio di preparazione: gli articoli del Viaggio nel Molise (’41), il saggio Del brigantaggio meridionale (dopo il ’45, rimasto incompiuto e pubblicato postumo), l’articolo Come ho visto la questione meridionale (’47).
Per le idee di fondo e il collegamento cronologico, Le terre del Sacramento sono l’epilogo di Signora Ava. Il contrasto tra “cafoni” e “galantuomini” che in Signora Ava è inquadrato agli albori dello Stato liberale, ora è visto nel momento più drammatico della nostra storia unitaria: il crollo dello Stato liberale e la sua resa al fascismo. IL momento conclusivo dei due romanzi è ugualmente tragico: alla repressione del brigantaggio fa da corrispettivo l’eccidio fascista dei contadini.
Nelle Terre del Sacramento interviene però il punto di vista maturato dallo scrittore con le ultime esperienze culturali e politiche e con le tensioni sociali a cavallo degli anni ’50: i “cafoni” non appaiono più una massa amorfa, stanno per acquisire la coscienza di avere diritto ad una vita finalmente umana.
La trama del romanzo è ambientata nel primo dopoguerra, negli anni che precedono la marcia su Roma e nei risvolti drammatici del fascismo in provincia.
I tremila ettari delle terre del Sacramento costituivano un antico feudo ecclesiastico espropriato dalla Stato con la legge del 1867 e passato alla famiglia Cannavale con regolare acquisto all’asta. L’immensa proprietà si estende ai piedi delle Mainarde, vicino a Calena (oggi Isernia) e a Morutri, ma è incolta ed abbandonata da tanto tempo per l’incuria dei proprietari e per il timore superstizioso dei contadini, ai cui occhi quelle terre sono maledette perché sono state confiscate alla Chiesa.
Esse, inaridite e sassose, sono diventate pascolo abusivo per i pastori e legnaia per i contadini.
L’avvocato Enrico Cannavale, ultimo discendente della famiglia, detto “la capra del diavolo” per l’umore bizzoso e la barba rossiccia, è il prototipo del ceto medio, la classe di “galantuomini” che dai tempi dell’unità è andata incontro ad una progressiva decadenza ed ha perso ogni consistenza economico-sociale.
Inetto e debole di carattere, con vaghe aspirazioni socialiste contraddette da una vita dissipata nell’ozio, tra sperperi ed avventure, non è persona adatta per riassestare il patrimonio famigliare e difendersi dai creditori, tra cui l’ambiguo fattore Felice Protto. Si sposa con una cugina, Laura de Martiis, e le affida la direzione degli affari; quanto a sé, continua a vegetare in una abulia che lo ridurrà ad un’ombra.
La moglie è ben diversa: riflessiva, realistica, non vuole farsi coinvolgere dall’apatia che sembra un’aria connaturata alla vita paesana di Calena. Si serve delle sue amicizie altolocate per ottenere dal Credito Meridionale il prestito necessario a rimettere in coltura la sterminata proprietà. Rimane un ultimo ostacolo: il rifiuto dei contadini a dissodare le terre sconsacrate.
A questo scopo, cera l’aiuto di Luca Marano e del prete don Giacomo Fontana.
Luca, figlio di poveri contadini di Morutri, avviato agli studi sacerdotali per l’ostinato desiderio della madre, lascia il Seminario quando si rende conto di non avere la vocazione e continua a studiare come può, frequentando saltuariamente l’università di Napoli e dando gli esami di legge quando ha soldi per pagare le tasse.
La sua vita quotidiana è fatta di ripieghi, come quella dei suoi compagni, poveri e senza avvenire; aiuta lo zio, ufficiale giudiziario, ma dai fratelli è considerato ugualmente un privilegiato.
Decisivi per lui sono due incontri; con Don Giacomo Fontana, un missionario tornato in vacanza a Calena, che gli insegna cosa sia il vero coraggio:
io -disse il prete- sono stato quarant’anni in Africa. Tu sai la riflessione più dolorosa che ho fatto in tanti anni? Ho visto migliaia di uomini e di donne crescere, invecchiare e morire con perfetto svolgimento della loro vita fisica. Ma la loro mente rimaneva immobile; morivano corpi di vecchi con cervelli di bambini. Erano uomini coraggiosi che si battevano contro le belve e tremavano di paura per la predizione di uno stregone. Erano temerari di corpo e vili di anima.
Ci sono due forme di coraggio -aggiunse parlando a sé stesso- uno fisico e uno mentale, io dovevo cercare di dare loro questo secondo coraggio (Terre).
Luca intende il messaggio e lo applica quando conosce donna Laura De Martiis, che lo invita a collaborare per il riscatto delle terre.
Si convince a fare da intermediario con i contadini, usa il suo ascendente per persuaderli a mettere da parte le paure superstiziose e promette, a nome del Cannavale, che le terre saranno date in enfiteusi in cambio del lavoro per coltivarle.
Don Giacomo a sua volta si offre per riconsacrare la cappella del Sacramento, più volte colpita dai fulmini, che i contadini interpretavano come un segno dell’ira divina. L’entusiasmo di possedere la terra vince la superstizione; i cafoni di Morutri, di Pietrafolca, in breve tempo trasformano il fondo: dissodano, arano e seminano.
Il denaro, però, finisce presto, le terre diventano proprietà del barone di Santasilia, e Laura Cannavale va via da Calena senza dare più sue notizie. Le promesse non possono essere mantenute e ai contadini giungono le prime ingiunzioni di sfratto. Essi dubitano anche di Luca che, invece, li raduna e li spinge ad occupare le terre.
La protesta intende essere pacifica ma le squadre fasciste, spalleggiate dai carabinieri, aprono il fuoco sulla massa dei contadini, donne, bambini. Muoiono Luca Marano, il suo amico Gesualdo, il contadino Marco Cece; la narrazione si chiude con un lamento funebre che la madre di Luca e le donne innalzano sui loro corpi.
In un romanzo di così notevole ampiezza, la forza e la validità artistica della rappresentazione sono il frutto di un rapporto armonioso tra tutti gli elementi che ne fanno parte: i personaggi principali, la coralità di un intero mondo contadino, le figure appartenenti ad altre classi sociali, gli eventi storico-politici, le vicende naturali legate al lavoro della terra, il paesaggio molisano, sempre rapportato ed inserito nel vivo del racconto.
Nel tratteggiare i personaggi, Jovine non si serve di un esame psicologico diretto, ne coglie la mentalità nell’ambiente: il suo realismo fa parlare le cose più che le persone.
Talora l’introspezione psicologica è colta di riflesso nel pensiero di altre figure.
Poesia e ideologia si fondono equilibratamente: i personaggi hanno un loro significato socialmente emblematico, senza risultare per questo meno veri e credibili; altrettanto veri sono i problemi e le realtà focalizzati nella narrazione.
Se Jovine esamina la condizione contadina più come gruppo che in ritratti individuali, ciò non significa vederla “dall’esterno” (N: Spegno, C. Salinari); non è squilibrio involontario ma scelta voluta per vari motivi: per la convinzione che la loro storia è uguale per tutti, per non eccedere nella pietà, e per non accentuare il distacco con i “padroni”.
L’intento è di analizzare obiettivamente tutte le componenti di un determinato cotesto storico ed esistenziale.
La simpatia per gli oppressi trapela, ma con discrezione, per la convinzione che Luca e Cannavale, Laura e Gesualdo sono espressione di una stessa situazione di fondo: “miseria e paura, superstizione, sono forse i termini più esatti per indicare i mali del nostro passato. Ed erano mali dei borghesi e dei contadini, sebbene si manifestassero in modo diverso” (F. Jovine, Lettera ed Alvaro in Aretusa, 1945, 2, p.33).
Enrico Cannavale, simbolo di una classe sociale che vive storicamente la sua rovina economica e morale, non è presentato con una condanna preconcetta ed è anch’egli oggetto di pietà umana.
Laura Cannavale è figura complessa, non sempre ben compresa dalla critica; a volte è considerata una velleitaria con idee umanitarie, a volte una fredda ed astuta calcolatrice con l’unico fine di un egoistico interesse economico.
La sua azione è determinata, invece, da molteplici ragioni.
Jovine colloca Laura nel gran mondo e pur le attribuisce dei motivi validi a giustificare i suoi eventuali errori: il peso della numerosa famiglia De Martiis cui deve provvedere dopo la morte del fratello; il matrimonio non certo d’amore con l’avvocato Cannavale; le preoccupazioni per il patrimonio dissestato del marito; la decisione di occuparsene nonostante la difficoltà dell’impresa; l’impegno per ottenere il denaro; le delusioni per le evidenti infedeltà coniugali; lo sforzo per non lasciarsi vincere dall’abulia misteriosa ed atavica di Calena.
Il suo calcolo di “ridare ordine alle faccende economiche del marito”, che si equilibra con la buona volontà di aiutare i cafoni di Calena e Morutri, non prevede una salvezza personale a scapito degli altri: Laura non specula su Luca né sul lavoro contadino.
Mette “da parte per il momento il groviglio di problemi e sentimenti” famigliari per spendere “le sue energie” allo scopo che si è prefisso. Comprime tutto dentro di sé senza mai lamentarsi o ribellarsi, sempre soffrendo e spesso scoraggiandosi.
Solo una volta accenna apertamente a Luca il suo tormento: “se potessimo fare quello che vogliamo -disse ancora- lei non immagina come è dura la mia vita”.
La sconfitta finale non è solo di Luca e dei contadini, anche Laura è stata ingannata dagli eventi e ripiomba nel suo dramma, dopo aver nutrito una breve illusione. Quando fugge a Sanremo non si può accusarla né odiarla.
Una problematica profondamente sentita da Jovine, e riproposta da un’opera all’altra, è il rapporto religione-superstizione che nel romanzo si intreccia in modo essenziale alle varie parti della vicenda.
La questione religiosa, non è stata adeguatamente studiata e solo ora si impone all’attenzione della critica joviniana; F. D’Episcopo (in Il Molise di Francesco Jovine, op. cit.) elabora proposte interpretative convincenti di cui è necessario tener conto.
“La ricerca di una “vera religione”, protesa verso un’autentica rivoluzione delle coscienze, scandisce i momenti chiave dell’itinerario narrativo joviniano”.
Jovine attribuisce alla dimensione religiosa incidenza umana e storica: ne rileva una presenza radicata nei costumi e nelle mentalità contadina e ne vede i riflessi nelle stesse condizioni sociali del Sud.
Egli indaga su tali realtà, -in prove narrative e in articoli giornalistici- muovendo la sua critica ai “poli devianti della superstizione e della magia”, -che spesso sono stati usati per asservire il popolo-, e, nell’ambito di una meditazione sempre più chiarificatrice, va alla sofferta ricerca delle radici autentiche del sentimento religioso. Fino agli ultimi scritti insiste in un progetto culturale capace di fondere la fede “illuministica nella ragione con le esigenze di stampo spiritualistico, per una finalità pedagogica della missione intellettuale che deve mirare a far acquisire una più matura “coscienza di se stessi”.
In Jovine la “coscienza di se stessi è coscienza della nobiltà, e dell’intrinseca divinità, della natura umana e, a suo avviso, può essere posseduta solo da una cultura “laicamente” impegnata in una inquieta e sofferta ricerca interiore di tali verità” (op. cit.).
Nell’allegoria delle Terre del Sacramento la figura di Luca Marano, per la sua vicenda biografica, esempla una maturazione umana, sociale ed anche religiosa.
Dopo la confusa crisi di coscienza che lo induce ad andare via dal Seminario, egli riceve una chiara lezione di riscatto e di salvezza da Don Giacomo Fontana; grazie a lui ripudia una “religione fatta più di paura che di speranza” e recupera un’”intimo ineffabile slancio dell’anima”.
E’ però Don Giacomo Fontana il vero personaggio-chiave per incarnare a livello teorico la “religione della speranza”.
“Alla religione del terrore magico e superstizioso, che sfuggiva ad ogni velleità di dominio logico, Don Giacomo sostituisce la religione della fiducia e della speranza nel controllo razionale del reale”, che può essere mezzo di elevazione del popolo e non più di soggezione.
Egli, che ha fiducia nella ragione, parta di “carità” come di “giustizia”.
L’acquisizione consapevole delle dure leggi che regolano il ritmo della storia è nata in Don Giacomo dalla lunga esperienza missionaria in Africa, tra gente di colore emarginata per ignoranza, superstizione, miseria, e quindi non molto diversa dai contadini meridionali. A quegli uomini, “temerari di corpo e vili d’anima”, egli ha cercato di dare il coraggio mentale.
A Calena, continua a battersi contro l’”irrazionale” paura di colpe non commesse, contro il degradamento del sentimento religioso, e non accetta le ragioni che hanno indotto il clero a sconsacrare la cappella delle terre.
Don Giacomo crede in un Dio che è “ragione”, è “ordine”, ed il suo impegno umanitario viene illuminato proprio dalla fede nella forza del ragionamento.
Quella forza che difettava all’inizio in Don Matteo di Signora Ava e difetta in Don Settimio, -altra figura chiave delle Terre-, che impersona il prete di campagna pigro, abitudinario e lontano da ogni desiderio di rigenerazione morale e sociale.
Il rapporto di Don Giacomo con Luca Marano è molto più articolato e significativo di quello tra Don Matteo e Pietro Veleno.
Pietro viene educato all’obbedienza, Luca viene aiutato a liberarsi dalla paura dell’ignoto, dallo spettro di sciagure passate e future, dai “veleni” diabolici della superstizione e della magia che proprio la madre, Immacolata, gli ha sempre evocato attorno.
Don Giacomo gli propone una concreta via per scongiurare tali maledizioni; quella di agire nella storia con l’aiuto della ragione e con una nuova coscienza della “grazia di Dio”.
Se Don Matteo, -nonostante l’adesione morale e materiale ai più deboli evidenziata nella conclusione di Signora Ava-, non riesce a trasmettere agli altri il miracolo della propria redenzione; Don Giacomo e Luca tentano, specie nella seconda parte delle Terre, di comunicare il messaggio di liberazione agli umili che li circondano.
Nella trama ampia delle Terre, Don Giacomo ha uno spazio narrativo più esiguo di quello che viene attribuito a Don Matteo in Signora Ava, e però più funzionale, per il suo ruolo sociale di sacerdote impegnato nel mondo con vivo senso di responsabilità storica e lucida volontà di azione per arginare le ipocrisie a danno dei poveri.
Jovine, in sostanza, auspica “il recupero della lezione cristiana, nel segno di una “coscienza” la quale, più che come sicuro possesso, tende a porsi come travagliata ricerca della verità, attraverso la difficile ricerca di se stessi e degli altri”.
Nel contempo, ribalta “il piano dell’assenza nella cronaca, in cui si muove l’eroe provvisorio del suo primo romanzo, in quello realistico della presenza in una storia, minata dai subdoli “veleni” dell’ignoranza e della paura, ma animata anche da una nuova fiducia nella speranza della salvezza” (cfr. F. D’Episcopo, op. cit., pp. 90-108).
A Luca Marano va l’obiettiva simpatia dell’autore; non è l’eroe che fin dall’inizio ha un marchio solo positivo, un “personaggio apostolico”, di cui parlano alcune definizioni critiche, perché Jovine non vuole fare “propaganda romanzata”.
Risulta anzi molto credibile nella figura umana e nella maturazione conseguita.
E’ credibile la prima in quanto lo scrittore, con realismo spontaneo, riesce a non dare troppo rilievo agli elementi epici presenti in Luca: bellezza, forza, intelligenza; e cerca di giustificarne la diversità dagli altri “cafoni” o il suo saper operare delle scelte, giuste o sbagliate che siano.
In Luca è credibile la fondamentale onestà, che lo spinge ad abbandonare la via sacerdotale per non mentire a sé stesso e agli altri visto che non sente una vera vocazione religiosa; e gli fa temere, una volta intrapresi gli studi di legge, di poter un giorno ridursi anche lui, -come tutti gli avvocati a Calena o altrove-, a sfruttare i poveri a vantaggio dei ricchi.
Credibile è la sua maturazione.
E’ un giovane studente provinciale, al pari di altri personaggi joviniani, ma l’estrazione sociale non è quella piccolo-borghese di Giulio Sabò, Giustino D’Arienzo, Siro Bagnini (per i quali la “provvisorietà” derivava dallo sradicamento provinciale e dall’impatto con la confusione cittadina).
La sua origine è contadina e a tale dimensione appartengono i dubbi, il complesso del povero, le illusioni, la morte; da rapporto con l’ambiente locale sono condizionate le sue aspirazioni.
Come Laura, Luca rischia di inaridire nell’inerzia indotta dell’atmosfera naturale ed ambientale che è sterilmente monotona.
E’ un tema costante, quasi ossessivo, nella coralità del romanzo: “… antica, mortuaria saggezza.
Era una scienza sepolta nelle pietre; a Calena era accaduto tutto senza modificare nulla” (Terre).
Come Gesualdo e tanti altri conterranei, Luca teme l’insabbiamento:
si veniva rifacendo la sua storia interna, a brano a brano, senza lume d’indulgenza per sé e per i suoi simili. Luca Marano, figlio di Giuseppe, non era più una vittima solitaria. Il suo destino, la sua tristezza di ventenne miserabile era simile a quella di Gesualdo, del canonico, di Ferdinando, delle migliaia di studenti che piovevano a Napoli tra ottobre e novembre, per esporre ai professori le nozioni lette nei manuali di Diritto Civile durante le desolate stagioni trascorse in villaggi come Morutri. Lunghi mesi passati a fumar cicche avvolte nella carte di giornale, mangiando lasagnette di farina grigia condite con aglio e peperoni fritti, accanto ai camini ingrommati di fumo… Giovani come lui, che si lasciavano intossicare l’anima senza speranze.
Domani avrebbero vissuto sfruttando, derubando subdolamente i contadini dei loro villaggi che erano legati alla loro stessa sorte, dalla stessa ingiustizia. Luca capiva ormai i legami sotterranei della sua tristezza con quella degli altri (Le Terre).
E’ una pagina che denota a pieno l’equilibrio di Jovine: nessun eccesso nel compianto, nessuna insistenza ideologica.
Luca, nel prendere coscienza che la “tristezza” è una condizione collettiva, non soltanto sua, trova il punto più alto di una maturazione etica e sociale che lo porta, a grado a grado, da un impegno casuale di intermediario tra il mondo dei contadini e quello dei “galantuomini”, alla comprensione dei problemi in atto, ad una diretta responsabilità di lotta per la conquista delle terre, ad una disperata ansia di giustizia che gli costerà la vita.
Tutto il romanzo è imperniato su tale lenta maturazione.
Luca non è l’intellettuale formatosi con gli studi e le teorie, è il giovane che vive chiuso in un soffocante ambiente naturale e partecipa giornalmente ai problemi della sua gente.
La sua maturità nasce da un’esperienza sofferta e rientra nei limiti storici e geografici della vicenda, cioè Luca non agisce sulla scorta di teorie marxiste, nel suo tempo ancora sconosciute al Sud.
Divengono così astratte e immotivate le critiche che lo accusano di immaturità politica, di essere “ruota dell’ingranaggio”, piccolo intellettuale vittima di un giro più grande di lui, di essere indeciso e romantico; o, al contrario, che lo salutano primo “eroe proletario” in lotta per un’acquisita coscienza di classe, e “intellettuale gramsciano”.
Jovine sa creare un personaggio vero perché conosce a fondo la problematica meridionale e tiene conto delle reali condizioni di vita e di mentalità in cui Luca agisce; la validità artistica è da cogliere proprio nelle ingenuità ed incertezze della sua azione, dato che non si sente capo dei “cafoni” e non ritiene di compiere un’impresa eccezionale (“Mi sono interessato dei contadini del mio paese ma spero di fare un altro mestiere poi”).
La sua morte è tanto più tragica perché non è la morte di un eroe votato al sacrificio fin dall’inizio, è quella di un giovane che lentamente ha fatto luce dentro se stesso; entrato quasi per caso nella lotta, ne percepisce dopo le ragioni ed arriva a diventarne il protagonista, -l’ingranaggio dell’azione-, per onestà e coerenza con i principi cui è pervenuto.
Al ritorno da Napoli, quando ha chiara la visione dell’inganno subito per le terre, vive un dilemma decisivo: abbandonare i contadini al loro destino o aiutarli a lottare.
Non si sente di tradire la sua gente di origine, è diventato consapevole del ruolo che gli spetta, per cui sceglie l’azione al loro fianco.
La decisione di occupare pacificamente le terre, con donne e bambini, nasce da un’esigenza di giustizia, non è ritorsione, ricatto:
bisognerà rimanere sulle terre notte e giorno per aspettare che ci facciano giustizia.
Noi abbiamo bisogno delle terre del Sacramento, sono il nostro pane.
Se noi siamo forti e uniti, dovranno ascoltarci.
Non vogliamo far male a nessuno, vogliamo solo lavorare (Le Terre).
Proprio per la dinamica presente nel personaggio, “la morte di Luca Marano e dei suoi contadini, non appare come sconfitta, ma come il prezzo del sacrificio di chi lotta, nella fede di un nuovo riscatto” (G. Giardini, op. cit. p. 61).
Il finale del romanzo, che è apparso ad alcuni critici un’inserzione mitologica, ieratica e musicale (Cecchi), un po’ fuori tono in un testo realistico, oppure letterario “lamento funebre… in un’aria tra epica e jacoponica” (Grillandi), è una scena realistica che documenta una tradizione popolare nel Meridione, un uso ancora vivo al tempo di Jovine che qui viene utilizzato in funzione ed a suggello del significato di fondo del romanzo.
Nel canto funebre sulla salma di Luca e dei suoi compagni, la madre e le altre donne lanciano un grido di rivolta e, nel contempo, un grido di speranza per un domani migliore ai propri figli, un domani non più di inganni e sangue ma solo di bene:
“per noi fame e dannazione
ma per i figli paradiso e pane”.
◊ ◊ ◊ ◊ ◊
Semplicità e naturalezza sono caratteri peculiari dello stile e della lingua, malgrado l’impressione di monotonia rilevata da Cecchi, De Robertis, Russo.
Jovine perviene al superamento della tentazione descrittiva o del tono “cantante” di Signora Ava, e l’assenza di musicalità, della “vena di canto” è un merito, non un limite, delle Terre del Sacramento.
Grazie allo sforzo di autocensura, la prosa è agile, semplice nella sintassi, aderente al soggetto della narrazione.
I dialoghi sono naturali, gli aggettivi essenziali, il periodare semplificato a proposizioni subordinative di primo grado, il lessico è sobrio.
Ciò permette una “lingua moderna, duttile, che si adatta… senza sbalzi alle battute dei “cafoni” come a quelle dei “signori”…E’ un risultato di straordinario equilibrio” (E. Ragni, op. cit. p.129).
Non si tratta dunque di piattezza stilistica ma è una delle operazioni linguistiche più notevoli della letteratura italiana del ‘900.
Tale esperimento, più che l’influenza dei contemporanei narratori americani, risente della lezione manzoniana e verghiana, rivissuta ed interpretata in modo originale.
La “coralità”, messa in rilievo da tutti i critici, è storico-realistica, non lirica; penetra in tutti i risvolti della realtà umana e sociale per ricercarne il più autentico significato.
Una coralità che permette di dare coerenza interna alla vita psicologica dei personaggi, verosimiglianza alle situazioni inventate, dinamicità alla struttura della società meridionale; una coralità che permette al lamento funebre finale di essere un giudizio severo su ciò che di tragico è accaduto e lo trasforma, malgrado la sconfitta del momento, in messaggio di fede e monito solenne per il futuro.
Messaggio e monito che danno intenso valore alle parole scritte da Jovine pochi giorni prima della morte (Lettera dal Molise, La Fine del Sanfedismo in L’Unità, II aprile ’50) ove annuncia con gioia:
Ma c’è qualcosa di nuovo in queste contrade.
Tratto da:
Francesco Jovine
Redatto a cura di: Anna Maria Sciarretta Colombo
Con la collaborazione di: Miranda Jovine Tortora
Della F.I.D.A.P.A (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) Sezione di Termoli (CB).